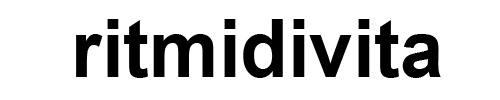Terre di Mezzo
Giungo nelle Terre di Mezzo come un soldato a cavallo, non percorro autostrade ma mulattiere impervie, i miei pensieri sfiorano torri d’avvistamento e case di pietra, immagino calzari ai piedi, armature ed abiti talari, spade e cristi lignei, eloquenti come i paesaggi. Il caldo è pungente, polveroso si insinua sotto il mantello.
Amata Umbria, tu che hai dato i natali al Francesco che abbiamo segregato tra i santi, amico di tempi che sembrano ormai estinti, amata terra, semplice come semplice era il suo saio, minuscoli i suoi passi, immense le sue orme. Lo immagino scivolare tra gli arbusti aridi e gli alberi modesti, tra i boschi fitti e incolti che coprono queste colline come presagi, lo vedo riposare in una grotta che si fa umida di notte, appena una fessura. Era piccolo Francesco, appena qualche spanna. Lo immagino bere ad una fonte, poi sedersi e guardare. Un cuore puro, mi ripeto, un cuore puro come il suo. Questo il mio mantra, ma è appena una brezza per la mia montagna interiore.
In piscina osservo i giovani, le famiglie, i bambini. Da una certa età in poi tutti hanno un tatuaggio, lo hanno fatto così, per estro, gli affidano indizi di personalità: dobbiamo distinguerci in fondo dal nostro fratello, stipati come siamo in quest’epoca di follia demografica. Del resto in tempi di omologazione ogni segno è lecito, fondamentale, rivela chi siamo – o almeno rivela che anche noi siamo.
Io chiedo, talvolta provocatoriamente, il significato di quella testa di donna o di aquila, di quella stella, di una rosa o di un serpente. Di quelle ali dispiegate o chiuse, in compressa attesa. Molti usano ideogrammi giapponesi, ne chiedo il significato. Chiedo perché mi aspetto storie fantastiche, mi basterebbe un sogno uscito da un cassetto intimo, o una visione dell’infanzia. Eppure tutto è più tiepido, più banale, mi dicono “mi piaceva”, così, come se lo avessero deciso dal parrucchiere, mentre qualcuno parlava di ceretta e un altro del cane della vicina. Lo riesco a tollerare trasportando me e loro in tempi passati, pensando alla folla che coi borghi nascenti si ammassava fuori le mura: mercanti, prostitute, mercenari – anche allora qualcuno probabilmente li osservava come me adesso, temendoli e studiandoli allo stesso tempo. E li temeva non per aver cara la propria vita, ma la coscienza.
Il fatto è che vaghiamo. Vaghiamo e quindi siamo stanchi, perché vagare stanca, essendo fatuo il passo e il gesto privo di movente. E’ un camminare largo, in cerchio. Uno sfiorare perenne l’obiettivo, senza mai coglierlo, mai farlo proprio.
Vagano le famiglie con questi bambini cui tutto è permesso, non hanno motivo per diventare grandi, nessuna conquista li attende, solo responsabilità adulte, sconosciute. Meglio restare piccoli, dunque, tanto si cena coi genitori al ristorante, si fanno le ore piccole di sera, si parla al cellulare, si esprime il proprio pensiero – con minor cartucce in canna forse, ma il lessico dei loro genitori non è poi più vario, anzi, “quattro concetti in croce” – li accuseranno poi, con la spocchia dell’adolescente.
Vagano gli uomini con le loro pance tonde, non so se il loro ultimo pasto li accompagna, quel pasto che colma i vuoti ma non li satura, o se invece nascondono un pallone, quel meraviglioso oggetto che permette loro – ma solo tra maschi! – di tornar bambini ed innocenti, bambini e spietati. Di tornare veri. Amo quelle pance e i palloni là celati. Vorrei dire loro, dai, venite, giochiamo. Non sarebbe un grande fuoco, forse, ma un piccolo falò di certo, qualcosa di sincero, la scusa per sentirsi più vicini, per guardarsi negli occhi.
Vagano le donne che parlano e parlano ancora tra loro, tendo l’orecchio ma il nulla ha un suono unico, colgo frammenti di un discorso che non conduce da nessuna parte. Vorrei parlare loro delle sorti del pianeta, dell’educazione dei figli, dell vita. Vorrei raccontare loro di Gesù, che non è mai stato nella chiesa del paese, mai nell’omelia del parroco, ma fuori le ha cercate, una ad una. Le ha chiamate per nome, Lui come il Buddha i nomi li ha sempre letti sul volto, non gli devi raccontare nulla a gente come Loro. Un Buddha ti vede e sa, un Gesù ti ama prima di vederti. Ecco vorrei dire a chi mi sfiora che c’è questa opportunità per tutti noi. Ma tergiverso: sapere questo le farebbe sentire più accolte o più reiette? Dubito e quindi taccio, la banalità mi satura, alla lunga mi offende.
Accanto a me una coppia di ventenni, lei bella, niente da eccepire, la osservo con quella curiosità che è sete, la si riscopre davanti a ciò che incanta, che ci connette alla bellezza. Eros lo chiamavano i Greci, ma non aveva le accezioni maliziose del linguaggio odierno, indicava solo la capacità di vedere il bello ovunque. Io figlio di quest’epoca il bello lo cerco più miseramente dove è più palese, adesso in lei, ma mi accorgo presto che non emana nulla, non un pensiero, non un desiderio, o un sogno. Osserva il cielo priva di pensieri – e per questo la invidio – poi guarda il cellulare, poi ancora getta gli occhi verso un orizzonte vicino. In realtà l’orizzonte c’è davvero, è Sant’Erasmo, promontorio bellissimo, con la sua chiesa romanica in cima, si erge proprio dietro di lei, basterebbe girarsi e… Lei invece se lo lascia alle spalle, guarda verso la piscina, chissà, i bambini, il ristorante, gli schiamazzi in acqua. Qualunque cosa sia non la emoziona, resta tiepida, distante. Vorrei portarle un libro, una storia, un sogno perduto, ma cosa leggerà? Poi si accende una sigaretta, scopro che ha un ragazzo solo allora, fanno gesti speculari, quasi identici. Ma dai tatuaggi diversi so che sono due, non uno.
Torno ai bambini che corrono impazziti, con i genitori che gli dicono quei “no” che sono sempre “sì”, non semplici sì, ma sì gridati, gettati in faccia: i figli lo sanno, è la prima cosa che imparano, a più riprese. Prima da infanti poi da adolescenti forzeranno con recidiva l’uscio del potere per scoprire puntualmente che non c’è nessuno dentro. Ci sono oggetti, parole, attività – il padre lavora, la madre pure, hanno idee sul mondo, commentano il mondo – ma sono diamanti grezzi, perenni potenziali. Li vedranno appassire mentre loro crescono, poi si vedranno appassire essi stessi. E’ la grande ruota del Samsāra, il Buddha aveva detto il vero, con una lucidità spietata, simile ad una maledizione.
Eppure l’umbro ha la sua luce, mi ripeto, fioca ma esiste. Esso è semplice e quindi potenzialmente puro. Sa credere. Sa seguire orme infuocate. Come quelle di Francesco di Assisi, o di Fra’ Bernardino che di Francesco ha ereditato un luogo santo qui nella bassa Umbria: terra, cespugli e alberi e alcuni ruderi. Con l’aiuto di scouts d’Italia e di Europa ha negli anni ricostruito tutto, dalla chiesa all’orto, alla foresteria.
La sua giornata è semplice, essa stessa è il suo messaggio: ci si sveglia con la chitarra e i canti, si prega insieme, poi si lavora.
A quel punto si ha del tempo per sé, vuoto, bellissimo. Un lusso che costa pochi euro e tanta buona volontà. Tanta fede. Anni fa gli chiesi ingenuamente se potevo portare un gruppo di yoga, infatuato dalla santità del posto. Mi guardò serio, mi disse che non era necessario esportare credi e pratiche, che in quel luogo si pregava e lavorava, lo yoga potevo farlo in Veneto, dove vivevo. Un altro ci sarebbe rimasto male, non io. Lo guardai, mi vergognai della mia ingenuità, capii ciò che diceva. Da allora gli resto debitore, ma senza dirglielo. Lo vado a trovare, di tanto in tanto, come un monaco andrebbe a trovare un santo.
In piazza, al bar, vedo le solite facce di sempre, ma con un anno in più, per tutti. Loro giocano a carte, o gridano ad alta voce scherzi di paese che finiscono un attimo dopo, ma resta l’eco tra le mura antiche. Io mi perdo nel suono delle campane di chiesa come quando sbucciavo le ginocchia, e come allora osservo i paesani con la soggezione di chi è condannato ad esser forestiero, se gli occhi si incrociano sorrido, per essere complice almeno in parte.
La vita lenta qui mi affascina, le giornate si fanno immense come da bambino, ma il sonno mi coglie ogni pomeriggio e nel cadere sul letto mi sento già vecchio, lontanissimo da qualunque futuro immaginato.
Il pregio di questi luoghi è la vita quasi ferma, ma allo stesso tempo essa è una condanna che impedisce il passo a chi non sa farlo dentro. Sotto il sole forte sento solo le cicale, il mio respiro ne viene avvolto, sparisco in quel fragore estivo, paralizzato come il resto.
Più tardi mi trascino in piscina per allenarmi e sentirmi desto, poche ore ma è già miracolo serale. Nelle docce trovo tracce disadorne di adolescenti che non hanno avuto appigli di cultura, un rubinetto miete energia lasciando sgorgare acqua bollente, forse da ore. Lo chiudo, per bilanciare l’incoscienza del fanciullo distratto centellino la mia di acqua, spero che qualcuno faccia lo stesso per pagare il conto delle mie ombre, che mi aspettano altrove, nuvole nel mio cielo.
Poche ore più tardi mi accadrà poi di scoprire un’altra “cura” dell’acqua, un altro valore: sulla spiaggia di Santa Marinella, tra folle dal simpatico accento romano, a me così familiare, stipate in pochi metri di sabbia, incontro lo sguardo scaltro del gestore di uno stabilimento che, non pago del denaro raccolto dalle postazioni tutte strapiene, mi vende una doccia a 50 centesimi al minuto! Accanto a lui un altro gestore, più disponibile e con un evidente senso del pudore, mi regala due gettoni per la sua di doccia, che vende a 20 centesimi l’uno (sempre del tempo di un minuto, evidentemente una tradizione del luogo!) ma evidentemente si rende conto che si tratta di un abuso, forse anche perché è gelata.
Per me abituato a docce quasi-militari due gettoni freddi sono un lusso, ma più di altro il non sentirmi preso in giro, un accenno di ospitalità, questo apprezzo, lascio un grande sorriso.
Il gestore del negozio di alimentari non mi può più vedere, è evidente: ogni volta gli chiedo di quel prodotto bio o di quel detersivo ecologico, che non ha né può ordinare – ma alla fine mi confessa, quasi asfittico, che non lo ordinerebbe comunque, in paese non interessa a nessuno di cose come quelle. Provo a dirgli che Sangemini è un minuscolo ma fondamentale puntino su un pianeta che rischia di estinguersi, se non ci si sveglia in tempo. Proprio in questi giorni di lotta vana, donchisciottesca, rivelano alla radio che il pianeta Terra ha terminato le riserve dell’anno, ed è appena luglio! Tutto l’ossigeno producibile nell’anno è già stato consumato, e così per gli altri beni. Da ora in poi distruggeremo e basta, fino a Natale. Allora non basteranno Babbo e le sue renne.
Vorrei parlare loro dello yoga, cento volte più dolce e graduale di un San Francesco o di un Padre Pio, ma nel suo sorriso c’è un muro senza porte, io grido dal fossato intorno, nessuno può sentirmi tra gli alti merli.
L’altra notte mi sono svegliato con la terra che tremava. Ho pregato per il palazzo, perché gli Angeli lo tenessero nel cielo, scoprendo di aver poco senso di sopravvivenza, ma a mia madre pensavo. Solo al mattino scopro che nel paese non ci sono stati danni, ma altrove tanti, e feriti e morti.
Ogni volta che accadono calamità pesanti come questa mi ritrovo a singhiozzare non per coloro che se ne sono andati – siamo viaggiatori, presto o tardi andiamo per la nostra via – ma per coloro che restano, distrutti e soli. Loro sì, li vorrei abbracciare, perché ognuno di noi si merita una parola di commiato, un saluto, una carezza. Basterebbe un “sei stato importante, grazie, ora devo andare”. Ma la partenza spesso è uno spuntone di roccia, secco e taciturno.
Così mentre si scava tra le macerie di Amatrice qui a due passi tutto torna consueto e lieve, di quella leggerezza di fine agosto che altri non sentiranno, non quest’anno. L’estate va a finire, lei sì che si sa dileguarsi lenta, ma non per questo è meno dolorosa. Ci parla ritirandosi di ciò che è stato, e di ciò che non è riuscito ad essere. Forse domani, ma non oggi, non ancora. Tuttavia è una malinconia diversa, quella di settembre, ha in sé una bellezza. E questa coesistenza tra vita e non-vita, tra distruzione ed eterno scorrere, questo spietato incedere di kronos, il tempo che perennemente avanza, mi fa pensare a Ramtha, mio grande maestro di anni ormai lontani. Fu lui il primo ad osservare questa legge che miete insieme vita e morte, sofferenza e bellezza, tramonti sereni e buio immoto. Possiamo evitarlo? Possiamo forse uscirne?
Egli c’è riuscito, Buddha c’è riuscito, ed io? E noi?
Questa riflessione mi richiama alla pratica, programmo una lezione con alcuni amici, sarà pratica condivisa, e questo è bello. Colle, tramonto, tappetini svolti, per condividere con chi c’è e con chi non c’è, nell’intento che sia preghiera per coloro che restano, per coloro che aiutano chi resta, per coloro che sono volati altrove. Affinché ci possano essere tutti, proprio tutti. E ci sono, ve lo assicuro.